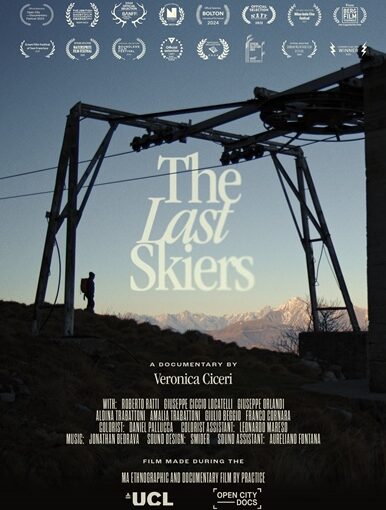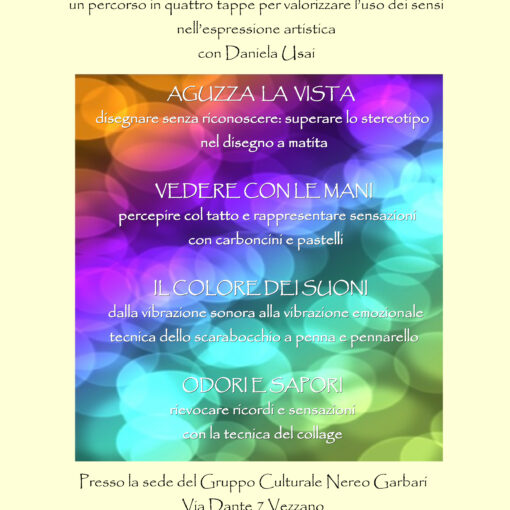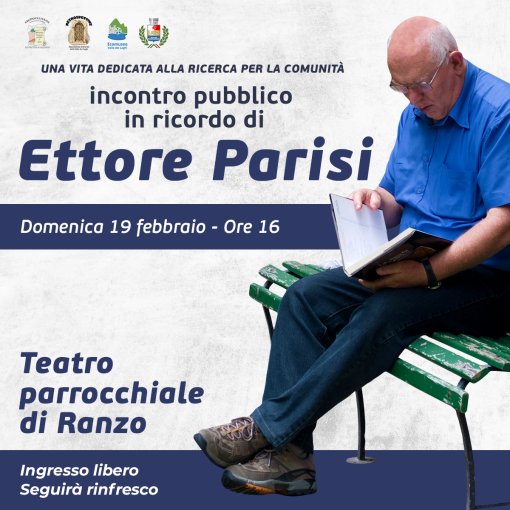L’invasione russa dell’Ucraina, cosa c’è stato prima, cosa ci potrebbe essere poi?

Grande partecipazione giovedì 8 giugno 2023, alla serata di approfondimento proposta dal gruppo culturale “N.C. Garbari” in collaborazione con APEIRON ed il patrocinio del Comune Vallelaghi.


Chi, entrando nella sede del Circolo Apeiron a Vezzano, fosse stato convinto che la motivazione principale del conflitto che ha coinvolto l’Ucraina avesse solo scopi umanitari e di tutela della popolazione del Donbass, ha dovuto ricredersi. Giorgio Comai, ricercatore del centro per la Cooperazione Internazionale ed esperto di spazio post-sovietico, ha spiegato chiaramente che il carburante che ha alimentato la macchina da guerra russa va ricercato più in profondità, nella percezione identitaria della Russia sia rispetto all’Ucraina che all’Occidente.
L’invasione su ampia scala di cui siamo ora testimoni è iniziata il 24 febbraio dello scorso anno ma la guerra in Ucraina c’era da anni, legata ai territori della Crimea e del Donbass. A partire dal 2022 i motivi che il presidente Putin ha annunciato a sostegno dell’invasione russa, validi ancora oggi, sostanzialmente si possono riassumere in tre punti: denazificazione e demilitarizzazione dell’Ucraina, tutela della popolazione del Donbass. Quest’ultimo punto ha avuto una grossa rilevanza mediatica ma non convince Comai che predilige le prime due ipotesi. Per la Russia sarebbe stato vantaggioso avere un vicino di casa non attivo militarmente e che non fosse indipendente. Finora la Russia non ha raggiunto questi traguardi, anzi, sta occupando territori che non avrebbe pensato di occupare ottenendo così solo un controllo diretto su ciò che non voleva o per cui avrebbe potuto stipulare degli accordi. L’Ucraina, da parte sua, non accetta alcun compromesso: non rinuncia alla sua indipendenza e, tanto meno in questo momento, all’ipotesi di una demilitarizzazione. Quindi quella che inizialmente era stata valutata dalla Russia come una breve guerra senz’altro vittoriosa, oggi si è trasformata in una lunga guerra di logoramento.
Un altro nodo cruciale della questione riguarda i rapporti della Russia con l’Occidente, in particolare con gli Stati Uniti. La percezione della Russia è quella di un Occidente collettivo che sembra volerla distruggere. All’inizio del 2022 la Russia chiedeva all’Occidente di stabilire un nuovo accordo per la sicurezza dell’Europa: la Russia avrebbe voluto tornare ad essere la superpotenza a cui veniva riconosciuto un ruolo imprescindibile negli affari internazionali. In gergo queste si chiamano “dinamiche di umiliazione”. La Russia aveva bisogno di riaffermarsi sulla scena internazionale dopo l’umiliazione subita uscendo sconfitta dalla Guerra Fredda. Inizialmente aveva cercato di cucirsi addosso il modello americano, dichiarandosi affezionata all’Occidente e applicando le riforme. Negli anni successivi, a partire dalla guerra in Iraq, la Russia ha capito che si trattava solo di un apparente avvicinamento e che, in realtà, non veniva ascoltata. Da parte sua l’Europa aveva fatto molto per accogliere la Russia e riconoscerle un ruolo speciale come testimonia il passaggio dal G7 al G8. C’è da chiedersi se avesse potuto fare di più ma, certamente, non si poteva fingere che la Russia fosse una grande potenza solo per non offenderla.
Si tende a sottovalutare quale sia il sentore dell’umiliazione. La disarmonia tra l’immagine che uno stato ha di sé stesso e la realtà è una dinamica classica che tutti gli imperi hanno sentito e passato nella loro storia. Anche recentemente ne abbiamo avuto esempio con la Francia e la guerra in Algeria o gli Stati Uniti e la guerra in Iraq dopo l’11 settembre. Si tratta di una dinamica pienamente europea e occidentale. Spesso dopo molte sconfitte le due immagini tornano a combaciare, è un processo difficile e nel lungo periodo inevitabile. Sarebbe auspicabile che la Russia riuscisse ad adeguare la percezione di sé alla realtà e definisse, quindi, i propri rapporti con l’Europa.
Con questa guerra identitaria la Russia ha iniziato ad essere stigmatizzata anche da paesi che non avevano preso posizioni dopo il 2008 e neppure dopo il 2014, con la guerra in Crimea e Donbass. Ci sono tre modi in cui una grande potenza può reagire allo stigma. Il primo è quello che sta perpetrando la Russia: accettare questa critica, ritenendosi una potenza diversa ma superiore alle altre che, prima o poi, la dovranno prendere a modello. La seconda modalità è quella di mostrare a tutti il proprio potenziale economico, sociale e tecnologico per rendere convincente la propria potenza agli occhi degli altri, come attualmente potrebbe fare la Cina. La Russia di Putin ha cercato di attuare entrambe le opzioni ma non ha avuto successo in nessuna di queste e Comai non le ritiene neppure realistiche. Nel lungo periodo, quando la guerra sarà finita, alla Russia non resterà che la terza modalità: cambiare il potere al vertice e sostenere che quanto è accaduto sia stato una parentesi, un’aberrazione. Le tesi degli studiosi che si occupano di scenari post bellici avvalorano questa ipotesi. Quindi non c’è nessun motivo di credere che il putinismo sia eterno. Questa è la via più auspicabile. Se anche in Russia si riuscisse a caratterizzare quest’invasione come un fallimento sarebbe possibile attuare questa soluzione nel medio periodo. Se ciò non dovesse accadere, si aprirebbe lo scenario peggiore: una guerra che durerà ancora per parecchi anni. Per buona parte della popolazione russa, però, si tratta di una guerra lontana che non permea il quotidiano. Non esiste la mobilitazione totale per cui non si è obbligati a combattere al fronte; la maggior parte della gente considera nulla la sua possibilità di influenzare le cose e quindi resta a guardare. Esaminando invece ciò che è stato imposto dall’Occidente si può affermare che le sanzioni stanno iniziando ad avere un impatto su molti settori economici e lo avranno anche nel lungo periodo limitando così la capacità bellica della Russia.
La questione delle armi resta una scelta delicata e difficile. Il parere di Comai come studioso è che, se accompagnato anche da un ragionamento politico maturo al riguardo, un sostegno anche militare di breve periodo all’Ucraina è la politica che rende più probabile un sistema di pace in Europa. Deve essere chiaro che una militarizzazione di breve periodo non ne implica necessariamente una a lungo periodo.

In conclusione, al di là del conflitto di cui ci siamo occupati in questo articolo, doverosa è un’osservazione sui sistemi di difesa. Sarebbe opportuno che tutti i paesi europei considerassero prioritario prepararsi a livello economico anziché militare. Investire nella difesa non si deve tradurre per forza in armamenti ma può essere inteso in modo più ampio: tutela rispetto ai repentini cambiamenti climatici, approvvigionamenti di principi attivi per le medicine e di materie prime necessarie per costruire la tecnologia che utilizziamo. Se si dedicano tante risorse alle armi e non a questo tipo di difesa, non saremo pronti a un prossimo eventuale conflitto, ad esempio con la Cina.
Un doveroso ringraziamento all’associazione Apeiron che ha messo a disposizione la sua sede e a Giorgio Comai, al quale va il merito di essere riuscito a dipingere un quadro più chiaro di ciò che sta accadendo poco lontano da noi, rispondendo con professionalità ai numerosi interventi in sala.